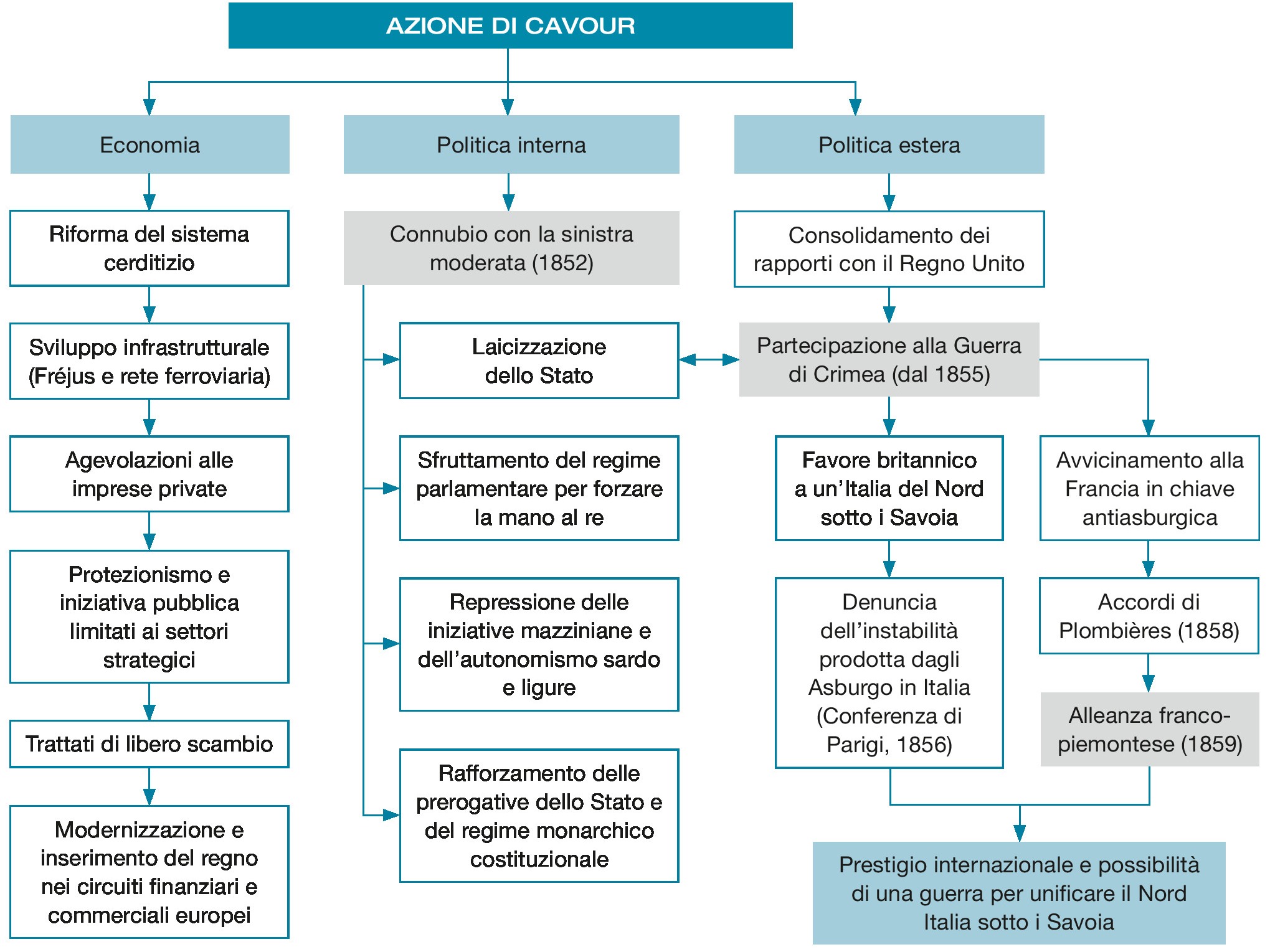L’esilio
Identità, ruoli e ideologie
Nel corso dell’Ottocento furono diverse le persone che dovettero espatriare perché invise ai regimi italiani preunitari. In larga parte si trattava di esponenti politicizzati dei ceti medio-alti (nobili, borghesi, studenti), e che dunque potevano disporre di denaro, reti di relazioni e competenze necessarie per vivere a lungo all’estero.
La presenza in America e nelle capitali europee di personaggi come Santorre di Santarosa, Giuseppe Mazzini, Daniele Manin, Carlo Pisacane, Francesco Crispi e Carlo Cattaneo contribuì alla costruzione di un’idea condivisa di nazione italiana e a sensibilizzare alla causa nazionale opinioni pubbliche e governi stranieri, anche se non ne determinò davvero le decisioni. Inoltre, in società ospiti che fissavano in maniera meno rigida i ruoli di genere, molte donne (come Cristina Trivulzio Barbiano di Belgioioso) poterono partecipare attivamente al successo del movimento risorgimentale, andando ben oltre i compiti di compagne, madri ed educatrici.
All’estero gli esuli più arditi acquisirono esperienza militare e fama, come Garibaldi, mentre altri crearono associazioni (fra cui la Giovine Italia), raccolsero fondi, tennero comizi, diressero giornali, organizzarono salotti e soprattutto produssero scritti e opere che valorizzavano e diffondevano la cultura italiana, denunciavano l’illiberalità delle dinastie regnanti e sollecitavano la mobilitazione per l’unità.
Il fuoriuscitismo non fu però un fenomeno esclusivamente italiano né contribuì solo alla formazione di un senso di comune appartenenza alla nazione italiana. Espatriati polacchi, ungheresi, greci, spagnoli e irlandesi ebbero infatti una parte non meno importante nelle vicende dei loro paesi e l’esilio, mettendo in contatto persone di nazionalità, culture, retroterra e idee differenti, favorì la creazione di identità multiple (l’“italo-greco” Ugo Foscolo), concezioni di appartenenza nazionale non fondate su base linguistico-culturale, e vere e proprie comunità transnazionali.
Oltre alle appartenenze, a subire continue ridefinizioni e impensabili ibridazioni era anche la piattaforma ideologica degli esiliati, che – proprio grazie al serrato gioco di confronti – poteva essere declinata in modo funzionale ai singoli contesti oppure diventare strumento utile ad ampliare liberalismi e progetti politici originariamente concepiti in un’ottica municipalista.
Gli affetti
L’esperienza dell’esilio aveva però anche un’importante dimensione emozionale e affettiva. Memorie e biografie mostrano infatti la pressoché totale sovrapposizione fra destino personale e nazionale degli esiliati, seppur vissuta diversamente in base al ceto, al genere, alla storia e all’indole dei singoli individui. I fuoriusciti mantenevano con le famiglie in patria rapporti diversi. Alcuni ne erano sostenuti idealmente e materialmente. Altri invece vi entravano in aperto conflitto, o per la mancata condivisione delle idee politiche (dei fratelli Pisacane, uno era legittimista, l’altro cospiratore) o per i danni provocati ai congiunti (confische, sorveglianza, discredito).
Allo stesso modo, l’esilio e persino la prigionia potevano essere occasioni per stringere unioni durature, come quelle fra Jessie White e Alberto Mario o fra Anita e Giuseppe Garibaldi. Al tempo stesso, però, potevano anche spezzare rapporti altrimenti solidi e costringere a scelte dolorose: a volte l’amore rappresentava un inaccettabile vincolo alla libertà di movimento e d’azione che la causa nazionale richiedeva, spingendo esuli eccellenti come Mazzini a «strapparsi il cuore dal petto» per non ostacolare l’adempimento dei «doveri verso la Patria».
Fu dunque grazie alle decisioni difficili, alle sofferenze e all’instancabile impegno di queste persone che una parte dell’unità d’Italia fu preparata e in seguito compiuta all’estero.