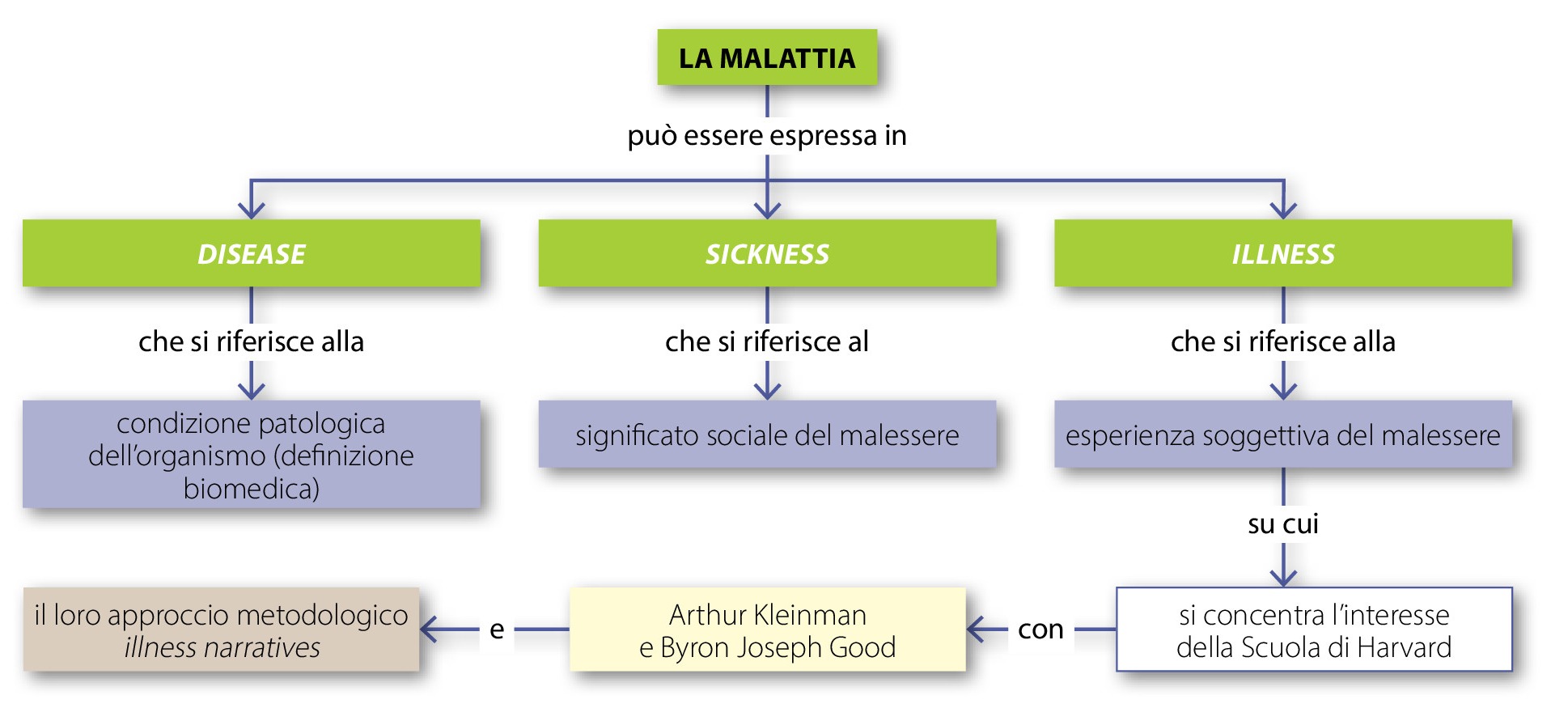3.1 Le emozioni
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto come il nostro corpo sia in parte il risultato di una costruzione culturale. Il corpo è infatti il mezzo attraverso cui gli esseri umani scoprono il mondo e imparano ad abitarlo secondo determinati modelli culturali, che vengono appresi tramite l’interazione sociale. Esso è dunque sia un prodotto biologico (fatto di carne, ossa, fluidi e così via), che costituisce la condizione di possibilità materiale di qualsiasi esperienza, sia un prodotto storico-culturale, in quanto riflette i processi di inculturazione che ci hanno reso persone in una data società.
Abbiamo visto come i modi in cui mangiamo, camminiamo, dormiamo non siano l’espressione di un corredo di istinti che possediamo fin dalla nascita, ma atteggiamenti fisici acquisiti attraverso processi di socializzazione e in seguito naturalizzati, cioè percepiti come spontanei e automatici.
Se quindi il corpo non è soltanto un’entità naturale, ma è il luogo in cui la cultura viene incorporata (embodied), qualcosa di molto simile può essere detto delle emozioni. Anche i modi in cui reagiamo emotivamente alle situazioni, infatti, sono culturalmente condizionati.
Per molto tempo, nell’ambito delle scienze umane, le emozioni sono state considerate pulsioni istintive, irrazionali e innate, attinenti più alla sfera naturale che a quella culturale. Questa concezione poggia su una serie di dicotomie profondamente radicate nella tradizione filosofica occidentale: mente/corpo, spirito/materia, razionale/irrazionale, natura/cultura, intelletto/passione. La consacrazione di questa visione dualistica come modello di pensiero dominante dell’Occidente moderno viene solitamente attribuita al filosofo francese René Descartes (1596-1650), noto come Cartesio, e alla sua concezione dell’uomo composto da una “sostanza pensante” (res cogitans) e una “sostanza fisica” (res extensa).
In un libro dal titolo L’errore di Cartesio, il neuroscienziato Antonio Damasio (n. 1944) critica il dualismo cartesiano per aver «disincarnato» la mente e «dementalizzato» il corpo; egli sostiene, al contrario, una concezione unitaria dell’organismo, caratterizzato dall’intreccio tra processi fisiologici, emozionali e cognitivi.