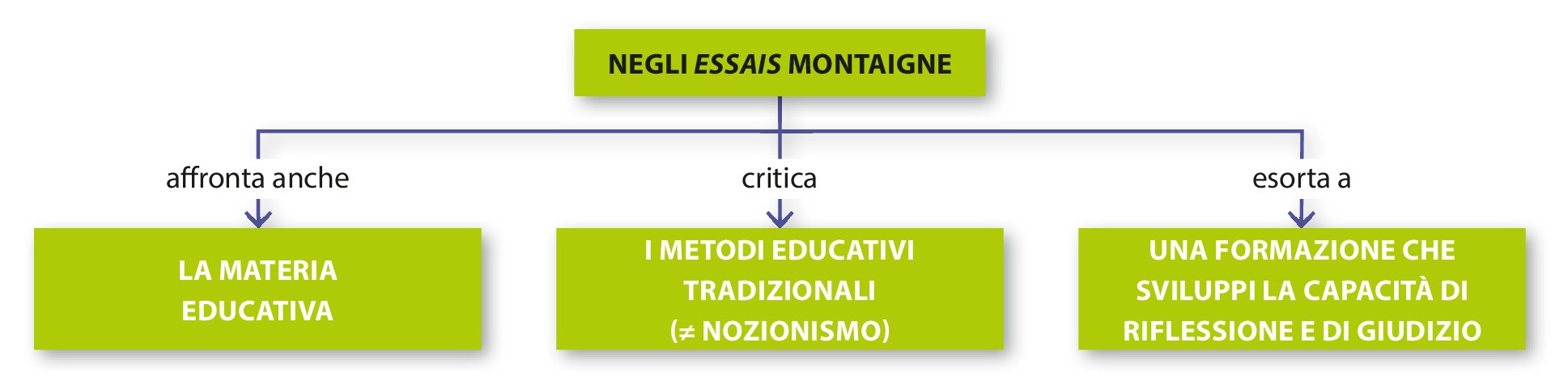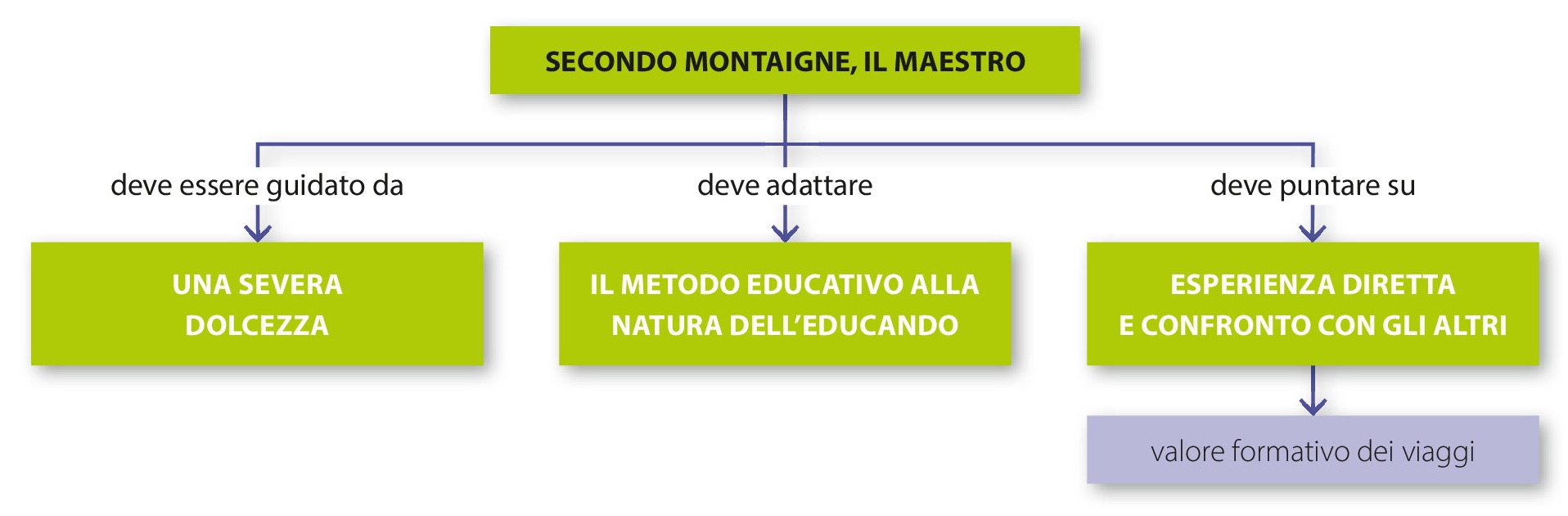Un esponente di spicco dell’Umanesimo francese è François Rabelais (1494-1553), che deve la sua fama al romanzo satirico-pedagogico Gargantua e Pantagruel. La prima parte dell’opera, articolata in cinque libri, esce nel 1532; l’ultima viene pubblicata postuma. In questo scritto Rabelais riassume la sua visione del mondo e critica apertamente tutte le ipocrisie del suo tempo. L’opera suscita subito molte polemiche e Rabelais riesce a evitare il carcere grazie ai suoi numerosi viaggi.
Il romanzo può essere considerato come una difesa appassionata della cultura umanistica e una critica severa alla cultura di stampo medievale. È la trama stessa dell’opera che fa giungere a queste conclusioni. Gargantua è un gigante, la cui formazione viene seguita inizialmente da maestri dotti e pedanti, che gli infarciscono la mente di nozioni tratte dalla vecchia cultura medievale. Il risultato è che Gargantua rimane ignorante e inetto, soprattutto quando viene messo a confronto con il paggio Eudémone, che ha ricevuto una cultura umanistica.
Allora il padre di Gargantua decide di affidare il figlio a un nuovo maestro, Ponocrate. Questi procede prima con la purificazione della mente di Gargantua, liberandola da tutte le incrostazioni derivanti dai precedenti insegnamenti, e poi lo introduce a una nuova metodologia educativa, incentrata sullo studio diretto dei classici, sul confronto con l’ambiente circostante e con il prossimo, nella quale c’è spazio anche per l’esercizio fisico e lo svago. L’impegno richiesto a Gargantua nello studio è significativo, ma viene affrontato con maggior soddisfazione e ben altri risultati rispetto al percorso formativo precedente.
A un certo punto Gargantua deve far ritorno nel regno di suo padre, per partecipare alla guerra scoppiata con il regno vicino. Il giovane gigante si fa onore sul campo di battaglia e sconfigge l’esercito nemico. Egli si mostra generoso con gli sconfitti e per porre le basi di una convivenza pacifica tra i due regni fonda una comunità educativa, l’abbazia di Thélème. L’abbazia è un luogo ideale, come la Città del Sole di Tommaso Campanella o Utopia di Tommaso Moro, in essa gli uomini vivono liberi e in pace, senza rispondere ad alcuna autorità.
Divenuto padre, Gargantua, consapevole del valore di una buona educazione, fa frequentare al figlio Pantagruel le più importanti facoltà universitarie. Mentre il figlio è a Parigi gli invia una lettera affettuosa, nella quale sottolinea l’importanza dello studio delle lingue (latino, greco, ebraico, caldaico e arabo) ed esorta Pantagruel a dedicarsi a numerose altre discipline: la storia, la cosmografia, l’astronomia, il diritto, la filosofia, la geografia, le scienze, la medicina e le Sacre Scritture.
Il modello di sapere a cui guarda Gargantua e, attraverso lui, Rabelais è di tipo enciclopedico, si propone cioè di raggiungere una conoscenza generale relativa a diversi ambiti di sapere, consapevole però che la sapienza deve essere nutrita dall’esperienza e sostenuta da una salda educazione religiosa.